L’infinito di Giacomo Leopardi in greco
È
una riflessione che ho in animo da tempo. L’articolo di Edoardo Boncinelli
uscito su «La lettura» dell’8 aprile 2018 ha contribuito a ricordarmene
l’urgenza. Un ragionamento sulla necessità di non sprecare le parole, di non
tradirle, e sulle conseguenze antropologiche derivanti dal quotidiano esercizio
al sovvertimento, alla destituzione dei loro confini segnati, ingenerando
quella confusa irresolutezza tra ciò che significano e ciò che tendono ad
adombrare, troppo spesso sobillato per ottunderle ed estinguerle quasi.
Lo
studio delle lingue antiche ha fatto sì che sviluppassi fin dall’adolescenza
anticorpi abbastanza efficaci verso certe banalizzazioni linguistiche. È pur
vero, però, che il bombardamento di banalità cui siamo sottoposti, scempi
verbali e non solo, giacché il linguaggio è veicolo e sismografo di quel che
una società ha scelto di divenire, insomma questo coacervo superficialissimo e dissonante,
filtra ovunque, anche laddove pensiamo di aver costruito argini sicuri. Mi son
chiesta spesso: se io che mi son forzata a studi del genere e ho ascoltato quel
che avevano da dirmi le cosiddette lingue “morte” – ma solo nel senso di non
esser più parlate da un paio di millenni, eppure vive ancor più della lingua
che parliamo adesso – se io stessa fatico a suscitare nelle parole un più autentico spirito, legante del linguaggio, come possono altri cui manca anche un tale confronto? Una lingua
morta oggi ha più facilità di riconciliarci con un uso verbale coerente
e onesto, di quanto non vi riesca la comunicazione di tutti i giorni.
La
risposta che mi son data sulle mie stesse inadeguatezze a fronte degli
studi classici, è piuttosto incalzante; anche questi studi risentono, fenomeno inevitabile, dell’epoca in cui son condotti, che da una parte è respingente,
se non ostile, alla loro sopravvivenza, processando tutto secondo le categorie
dell’inutilità e dell’utilità. Dall’altra, orientata com’è al generale abbassamento
del livello culturale, insidia anche chi con encomiabile
resilienza queste materie continua a divulgarle.
No,
non son proprio più i tempi degli «studi leggiadri», di Bessarione e dei grandi
maestri bizantini venuti in Europa dopo il crollo dell’impero d’oriente, di
quella mirabile, incredibile commistione di antico e moderno che prima diede
forma al volgare, portato al trionfo dai grandi del Trecento, quindi accompagnandosi
alla piena riscoperta del greco religiosamente destinato alla crescita della letteratura, che tra Cinquecento e
Ottocento contribuì a scolpire una visione del mondo. Nel bene e
nel male non si tratta ormai più di quella cultura certamente elitaria, anzi
elitarissima, a sua volta fin troppo settaria, ma che ha anche prodotto nella
nostra lingua capolavori eccelsi.
Ai
nostri giorni è perfino nata – orrore – la letteratura commerciale dell’antico,
definita talentuosa e innovativa da alcuni tra i più prestigiosi organi di
stampa occidentali e tradotta addirittura nei templi stessi dell’antico. Come si vede
il morbo è in estensione. Perché oggi tutto deve sforzarsi di essere
comunicativo. Nei tempi dello sdoganamento di internet sorgono strane figure
che si dicono animate da sana e disinteressata divulgazione, in realtà investite,
oltre il limite di guardia, da un insano accanimento verso le pratiche
comunicative. Nascono i censimenti dei poeti – e quanti bei nomi mancano
all’indice – e le poesie attente alla comunicazione, a come dovranno
diffondersi e incontrare il gusto del lettore e farsi notare; con
l’imbarazzante risultato, non occorre neanche dirlo, di comunicare molto poco.
Un Eugenio Montale, un Dino Campana, un Alfonso Gatto, non si son preoccupati
di esser comunicabili al di là dei loro versi, eppure son ben lontani dal veder
esaurita nella loro opera la potenza di una significazione. E se penso a un
personaggio ingombrante e assai più rumoroso come Gabriele D’Annunzio, che
molto ha voluto comunicare di sé e dei modi del suo esercizio creativo, non
posso comunque fare a meno di considerare l’infinito raccoglimento che è alla
base del Notturno e l’intimismo colto
dell’Alcyone: entrati di diritto nella
letteratura italiana. Possa piacere o no il personaggio, ma nelle sue
esternazioni, anche le più ridondanti, vi era una volontà comunicativa ispirata
da una visione, che ha anche saputo ritrarsi, quand’era il caso. Nulla a che
fare con il rumore di fondo di tanti odierni cosiddetti comunicatori
dell’essere illetterati.
Ho
raccolto, saranno passati non più di tre o quattro anni, alcune espressioni che
mi è capitato di sentir ripetere con insopportabile frequenza, esempi a mio
parere di quello scadimento della lingua, e quindi dell’etica del parlante, che
dicevo all’inizio. Le elenco qui brevemente a suffragio del ragionamento che
motiva questo scritto.
L’abuso
dell’aggettivo epocale. Nelle belle pagine del saggio di Paolo Chiarini
sull’espressionismo tedesco suonava storicamente motivato e animato, se
vogliamo, da una sua grazia letteraria. Da dopo aver letto questo libro, sarà stata una pura
coincidenza, anzi di certo lo è stata, “epocale” divenne quasi tutto. Notai che
l’aggettivo era usato con una disinvoltura agghiacciante che ottundeva
qualsiasi concetto: anche la passeggiata del cane del vicino aveva in qualche
racconto un che di epocale. Il risultato fu, ed è ancora, che mi son quasi
vergognata di averlo utilizzato per la recensione di Chiarini e forse per un
paio d’altri articoli.
Come tralasciare quindi il sempreverde scontro di civiltà, che torna puntuale nel
dibattito oriente-occidente. E un’espressione del genere, non occorre dirlo,
non aggiunge nulla al dibattito. Segue a ruota l’ossessione per il populismo, chiave di lettura sempre pronta all’uso e spauracchio di ogni analisi
politica. Nella vacuità imperversante delle analisi bisognava inventarsi un
riempitivo.
Prima o poi arriva chi si è rimboccato le maniche. Un modo di dire proprio insipido, in senso etimologico. Si è soliti sentirla pronunciare nelle difficoltà che non
hanno visto concretarsi alcun aiuto. Dunque, chi fa da sé si rimbocca le
maniche, oppure bisogna convincersi che, siccome di aiuto non se ne parla,
anche quando sarebbe dovuto, “è necessario rimboccarsi le maniche”. Alter ego
dell’italico arrangiarsi; la crisi economica ha inchiodato queste espressioni
alla loro misera incapacità senza via d’uscita. Nei tempi attuali, che tu ti rimbocchi le
maniche o tu ti arrangi, è sempre abbastanza dura. Ripetuto tante volte, come
avviene nel marasma linguistico dell’ora e adesso, diventa sintomatico di
un’impotenza collettiva scoraggiante.
Procedo
con una memoria personale, un colloquio con un imprenditore orafo e la sua
servizievole segretaria, donna di consolidata incompetenza e senza alcuna
attitudine per lo stare al pubblico – a questo punto arriva l’altro tipico
pensiero maschile, che sussume molte aggiuntive banalità e pregiudizi divulgati
dalla nostra cultura “bella donna?”. No, non era una bella donna. Al termine del
nostro confronto – cercavo uno sponsor per un’iniziativa culturale – è giunta la
conclusione che nulla intendeva concludere: «ma io voglio vedere i
risultati!». Questa affermazione ho avuto modo di ascoltarla e soppesarla
diverse volte, in contesti apparentemente lontani, e non ha smesso di trasmettermi
la sua abbacinante inutilità quando non si ha nulla da argomentare.
Infine
poche altre perle di saggezza. L’inflazionatissimo, soprattutto da parte
femminile, “mettersi in gioco” – a un certo punto c’è sempre una donna che ha
voglia di mettersi in gioco. E quindi? Provate ad ascoltare una qualsiasi
trasmissione televisiva, arriverà senza farsi attendere troppo. Sono qui perché
mi sono voluta mettere in gioco…E allora? Il fastidio di questa salottiera autodafé
sta nel fatto che si tira dietro in automatico la domanda di chi la subisce: e
a me che…? Abbiamo poi, in chiusura, il celeberrimo “purtroppo c’è crisi” – lo
abbiamo sentito fino allo sfinimento in questi anni di risposte mancate a
qualsiasi richiesta – l’isterico “d’altra parte si vive una volta sola”, il
gelido e inquietante, per l’associazione che instaura con un’ipotetica
pandemia, “è diventato virale”.
Ci
sono poi, e anche qui non basterebbe scrivere un manuale, le pseudo dialettiche
da social. Una discussione, se mirata all’attacco personale, si svolgerà sempre
tirando dentro le stesse identiche argomentazioni – provate a scorrere un
qualsiasi alterco tra due utenti: sarai mica permalosa (se fai notare che ti hanno scritto un’imbecillità), vai fuori argomento, denoti debolezza, hai un livello
proprio…e poi scattano le offese, perché quello era il proposito (e
la provocazione) iniziale, ovviamente.
Aperta
questa parentesi sulle peggiorate condizioni della lingua, sui suoi innumerevoli
tic, e i limiti culturali e psicologici di una parte consistente degli
interlocutori coinvolti, desidero evidenziare un epilogo ulteriore di questo
generale scadimento. È una conseguenza ben introdotta a mio avviso dal citato
articolo di Boncinelli, quando ci fa presente che nel riferimento, ad esempio, alla parola “natura” non sappiamo più a che cosa vogliamo richiamarci, e tutto si
riduce molto spesso a uno sconcertante guazzabuglio semantico.
La
conseguenza, dicevo, altrettanto confusa e pericolosa è la facilità con cui si
ricorre nel ragionare agli anestetici. Mi spiego
meglio: se alla parola guerra non riesco ad attribuire il senso che la guerra
ha effettivamente, ogni discorso contro o a favore è suscettibile di una
reazione neutra. Come posso schierarmi se in quello
che si afferma non vi è contenuto, contesto, storia, polemica, insomma un vissuto? Mi sono molto arrabbiata leggendo ultimamente certe discussioni sugli aiuti ai
terremotati. Secondo alcuni opinionisti parlare di certi problemi è
sciacallaggio politico. Al che sono intervenuti alcuni residenti nel cratere
sismico, giustamente risentiti – chi più di loro ha diritto di parlare? –
sostenendo che la discussione, perfino lo scontro, a livello di istituzioni è
vitale e non significa strumentalizzazione. Quel che uccide, direi in generale,
è proprio questo anestetico a buon mercato che vuole smussare le opinioni,
abbassare i toni ed esser gentile, ma nelle risultanze ha il volto efferato dell’ignoranza e dell’indifferenza. Dire una parola e tradirla, dare una parola e non
mantenerla. Sintomo di paralisi culturale, etica ed economica. E di tanta
scrittura e letteratura che non sono proprio, neppure lontanamente, né l’una né
l’altra.
(Di
Claudia Ciardi)

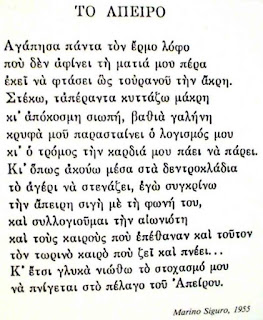
Nessun commento:
Posta un commento