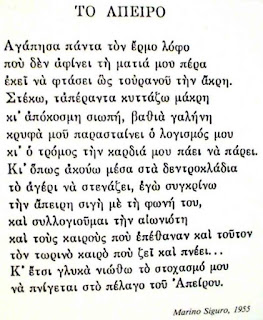Un saggio di storia tra i più profondi, estesi e stimolanti degli ultimi cinquant’anni, dove cronaca, commento agile e disinvolto dei fatti, analisi sociologica e teoria politica s’intrecciano
mirabilmente, facendo appassionare il lettore a vicende altrimenti poco
note, eppure non così lontane nello spazio e nel tempo. Ci aggiriamo infatti
negli avventurosi e turbolenti secoli che preparano il terreno al
consolidamento degli Stati moderni, tra la metà del Cinquecento e il Seicento,
periodo di cambiamenti sociali, in qualche caso sarebbe più opportuno dire
scivolamenti, e anche repentine battute d’arresto. Il libro è Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età
di Filippo II, la sterminata opera di Fernand Braudel, in Italia
pubblicata da Einaudi a partire dalla metà degli anni Sessanta e subito al
centro di un fervido dibattito. Inutile dire che siamo davanti a uno di quei
monumenti sacri investiti del ruolo di attrarre e convogliare attorno a sé
energie nuove della storiografia recente e della sua teoria, innovando la disciplina in alcune delle principali articolazioni che le sono proprie.
Bastano
scorci di questo tipo: «Siviglia, ottobre 1581: i vagabondi fermati in una
retata della polizia sono imbarcati di forza sulle navi di Sotomayor [l’artefice
del disastro dell’invincibile armada], dirette verso lo stretto di Magellano.
Erano destinati a fare gli sterratori, i guastatori, ma quattro legni colarono
a picco durante la traversata e mille di quegli sventurati finirono annegati»,
oppure «in Sicilia le imprese dei briganti erano cantate dagli “urvi”, cantori
ciechi itineranti, che si accompagnavano con una specie di violino polveroso, e
che la folla circondava avidamente sotto i platani dei viali». Bastano, si
diceva, questi quadri vividi tratti dai resoconti del tempo, che Braudel con
l’agilità del grande studioso riassume in poche pennellate e fa tornare attuali,
per farci toccare con mano il passato e scoprirlo sorprendentemente contiguo, e
per dare al suo lavoro un taglio che non è esagerato definire letterario. Del
resto a fornire tutti gli ingredienti è proprio il gran teatro della storia,
cui lo scrittore guarda. La severità tracotante, nutrita del più arcaico e
immobile feudalesimo, dell’aristocrazia, le ambizioni di una borghesia
mercantile che tuttavia è ancora poco cosciente del suo ruolo di classe, uno
Stato moderno consolidato ma al contempo dai confini ancora incerti, che vive
d’innumerevoli compromessi e appoggi nella classe nobiliare che ancora fino
a tutto il Seicento orienta i giochi di potere. Ma
pure si tratta di una nobiltà ambigua, sfuggente, che attraversa rovesci
pesantissimi e si apre, di necessità, agli innesti di nuove personalità, di
grandi mercanti e banchieri che avevano fatto fortuna lontano dalla terra e che
a un certo punto alla terra vogliono tornare. Infine la massa di contadini,
poveri, vagabondi, avventurieri, rovinati delle congiunture economiche sfavorevoli, che sulla fine
del Cinquecento divengono una sconcertante realtà con cui le culture
mediterranee si trovano a fare i conti. Picari, briganti, pirati, ladruncoli di
strada, mercenari, imboscati, prostitute, vedove in cerca di nuovi redditieri,
rivoltosi, disoccupati per costrizione o per volontà di non voler andare sotto
un padrone. Le torme di diseredati che scendono dai monti verso la pianura,
affluendo nelle campagne di Spagna o sulle coste provenzali o nell’entroterra
italiano, al solo fine di razziare, sono connaturate alla storia mediterranea,
dai Pirenei al Marocco. Talora divengono protagoniste di sommosse, anche
violente, ma brevi e subito brutalmente strangolate dagli eserciti o da altri
mercenari, in qualche caso quella stessa gente che viveva in
promiscuità con tali compagni di strada, assoldata dal signore di turno per far pulizia.
È
un mondo in subbuglio che Braudel inchioda alle soglie di un pauperismo in
deciso aumento in tutte le civiltà che si affacciano sul Mediterraneo.
Sovrappopolazione, violenza dei potenti, soprusi di Stato, graduale o improvvisa uscita di scena di
quelle borghesie mercantili che avevano saputo attrarre ricchezze e metterle in
circolo nella società, costituiscono una miscela infiammabile, destinata a
rimescolare di lì a poco equilibri e certezze. «Un lungo e intenso lavorio in
profondità elaborò a poco a poco e trasformò le società mediterranee, dal 1550
al 1600, concludendo una lunga gestazione. Il malessere generale e crescente,
pur non traducendosi in rivolte palesi, modifica nondimeno tutto il paesaggio
sociale. Ed è un dramma innegabilmente di carattere sociale. […] Indubbiamente,
tutto tende a polarizzarsi tra una nobiltà ricca, vigorosa, ricostituita in
famiglie potenti sostenute da vasti beni stabili, e una massa di poveri sempre
più numerosi e miserabili, “bruchi o maggiolini” [così si legge nelle cronache d’epoca], insetti umani, ahimè
sovrabbondanti. Un cracking spacca in due le vecchie società, vi scava baratri.
Nulla li colmerà: neppure, ripetiamolo, la straordinaria carità cattolica di
fine secolo. […] La crisi dà i suoi colori alla vita degli uomini. Se i ricchi
bazzicano con la canaglia, si mescolano più facilmente alla folla che
disprezzano, vuol dire che la vita ha allora le sue due rive vicine; case
nobili da un lato, sovrappopolate di domestici; picardìa dall’altro, mondo del
mercato nero, del furto, del vizio, dell’avventura e soprattutto della miseria…
Analogamente, la più pura, la più esaltata passione religiosa si accosta alle
più sorprendenti bassezze e brutalità. Singolari e meravigliose contraddizioni
del barocco, si è esclamato. No, non del barocco ma della società che lo
sostiene e lo ricopre male. E, nel cuore di queste società, quale disperazione
di vivere!». Questo il commento conclusivo a una delle sezioni più avvincenti
del libro, il capitolo V dedicato alle società e alle loro incongrue,
complesse, affatto scontate trasformazioni, di cui intendiamo qui rileggere
alcuni passi salienti. Se non è vero che la storia si ripete esatta, è invece inconfutabile che la sua conoscenza approfondita aiuti a capire meglio chi siamo.
L’approfondimento di alcune delle dinamiche riportate alla luce dall’enorme
lavoro di scavo di Braudel è un dono quanto mai prezioso che di certo non ha ancora esaurito il suo messaggio.
(Di Claudia Ciardi)
«Nel
vasto campo mediterraneo del secolo XVI, l’evoluzione delle società appare
abbastanza semplice. A patto, evidentemente, di limitarsi all’insieme, di
trascurare i particolari, i casi locali, le aberrazioni, le occasioni perdute
(che furono numerose) e i rivolgimenti spesso più drammatici che profondi:
sorgono, poi spariscono.
Questi
sconvolgimenti, è evidente, hanno la loro importanza. Ma le società di allora,
a base terriera, si evolvono lentamente e sono sempre in ritardo sulla politica
e sull’economia. E le congiunture sociali sono come tutte le congiunture, ora
in un senso, ora nell’altro; spesso finiscono col compensarsi, così che, alla
lunga, l’evoluzione effettivamente compiuta resta poco avvertibile. In Francia,
probabilmente hanno giocato forti alternative: tutto il primo secolo XVI è
sotto il segno della mobilità sociale, i poveri si spostano da un punto
all’altro, da una regione all’altra, senza soccombere nel corso dell’avventura;
in pari tempo, in verticale, lungo la scala sociale, ci sono ricchi che cessano
di esserlo e sono sostituiti da nuovi ricchi; poi, verso gli anni 1550-60 si
osserva un rallentamento, e il movimento riprende più tardi per bloccarsi
ancora, forse fin dal 1587 in Borgogna, o verso il 1595, sull’ora mondiale
dell’inversione della tendenza maggiore. Abbiamo così di volta in volta,
un’accelerazione, un ritardo, una ripresa, un ristagno, e tutto ciò porta, ma
solo momentaneamente, alla vittoria evidente delle aristocrazie, e solo sul
finire del secolo, a un semiblocco delle società. Questa realtà, però, è ancora
un risultato congiunturale, di quelli che possono scomparire o essere
compensati dall’ondata successiva» [si
cita in proposito il Drout “Mayenne et la Bourgogne”: «Questi legulei, che
avevano da un secolo sconvolto il vecchio ordine sociale, verso il 1587
formavano già un corpo conservatore. Volevano mantenere il regime che aveva
favorito la loro ascesa, e il pane che poteva garantire il loro avvenire.
Tendevano anche ad isolarsi come classe sulla sommità conquistata»].
Il
secolo XVI, insomma, nonostante le sue esitazioni o a causa di esse, non ha
rimesso in discussione le vere basi della società. In complesso, le accetta e
le riceve, già pronte, dalle epoche precedenti; e a sua volta le accetterà il
secolo XVII. […] Una nobiltà alle prese con continue difficoltà finanziarie, a
cui tuttavia sopravvive; uno Stato moderno che non riesce a compiere la sua
missione e a realizzarsi come rivoluzione sociale (si accontenta di
compromessi, gioca alla coesistenza); una borghesia che continua a tradire – ma
si riconosce forse come patria sociale? – ; infine un popolo inquieto,
scontento, agitato e tuttavia privo di una vera coscienza rivoluzionaria».
[…]
«All’epoca
di Enrico II, la nobiltà francese importava, ogni anno – così si diceva – capi
di abbigliamento per quattro milioni di lire, provenienti dall’Italia. Ma le
apparenze non escludono, anzi richiamano le realtà tangibili della potenza,
della ricchezza… Su spazi immensi, quelle nobiltà vivono della linfa e delle
vigorose radici feudali. Un ordine antico fa capo a quei privilegiati e ancora
li sostiene. Le sole eccezioni sono intorno o all’interno delle grandi città,
corruttrici delle antiche gerarchie, sono nei centri mercantili (e ancora), nei
paesi arricchitisi per tempo, quali i Paesi Bassi e soprattutto l’Italia, ma
non tutta l’Italia.
E
queste eccezioni? Punti minuscoli, zone ristrette. Su scala mediterranea ed
europea, si tratta, evidentemente di una storia minoritaria. Di quel vasto
complesso, possiamo ripetere ciò che diceva Lucien Romier della Francia di
Caterina de’ Medici, nella quale tutto diventa chiaro “non appena le viene
restituita la sua cornice naturale, un vasto regno semifeudale”. Per ogni dove,
lo Stato, rivoluzione sociale (ma appena abbozzata) quanto politica, deve
lottare contro “quei possessori di feudi, padroni dei paesi, dei campi, delle strade,
guardiani dell’immenso popolo rurale”. Lottare, e cioè venire a patti con essi,
dividerli, e anche proteggerli, perché è impossibile tenere in pugno una
società senza la complicità di una classe dominante. Lo Stato moderno prende
nelle sue mani quello strumento, e se per avventura lo spezzasse, tutto sarebbe
da rifare. E creare un ordine sociale non è cosa da poco, tanto più che
nessuno, nel secolo XVI, ci pensa seriamente.
Così,
nobiltà e feudalità hanno dalla loro il peso delle consuetudini, la forza di
posizioni da tempo tenute, per non parlare della relativa debolezza degli
stati, o della limitata immaginazione rivoluzionaria del secolo».
[…]
«Nel
secolo XVI, la borghesia, legata al commercio e al servizio del re, è sempre
sul punto di perdersi. Essa non rischia solo la rovina. Se diventa troppo ricca
o ne ha abbastanza dei rischi della vita mercantile, eccola acquistare cariche,
rendite, titoli o feudi e lasciarsi tentare dalla vita nobiliare, col suo
prestigio e i suoi ozi tranquilli. Al servizio del re si diventa nobili
abbastanza rapidamente; anche per questa via, che non esclude le altre, la
borghesia si perde. Essa rinnega se stessa, ancor più facilmente perché, nel
secolo XVI, il denaro che distingue il ricco dal povero vale già come un pregiudizio
di nobiltà. E poi, alla svolta tra il XVI e il XVII, gli affari segnano il
passo, respingono i prudenti verso la terra e i suoi valoro sicuri. E la terra
è aristocratica per vocazione. «Molti dei principali mercanti fiorentini sparsi
per le diverse piazze dell’Europa – racconta il Galluzzi nella Istoria del Granducato di Toscana –
secondando il genio del granduca portarono in Toscana i loro fondi per
convertirli in terreni, ed applicarsi all’agricoltura; in conseguenza di ciò
ritornarono da Londra i Corsini e i Gerini, i Torrigiani da Norimberga e si
fecero fiorentini gli Ximénes, mercanti portoghesi, i quali ben volentieri
concorsero a covertire in tante terre in Toscana le loro ricchezze…». […] Non è
eccessivo parlare di un fallimento della borghesia, a condizione di portarsi
abbastanza avanti nel secolo XVII. La borghesia era legata alle città; ora, le
città conobbero una serie di crisi politiche, come la rivolta dei Comuneros
spagnoli nel 1521, la caduta di Firenze nel 1530. Le libertà cittadine ne
soffrirono molto. Poi vennero le crisi economiche; prima transitorie, poi, col
secolo XVII, persistenti, esse intaccano profondamente le prosperità della
città. Tutto cambia, deve cambiare».
[…]
«Sui
poveri la storia getta ben poche luci, ma essi sanno, a modo loro, attirare
l’attenzione dei potenti di allora, e di rimbalzo anche la nostra. Disordini,
sommosse, rivolte, preoccupante moltiplicarsi di “vagabondi e girovaghi” [“erranti e vagabondi” è la definizione dei
consoli e scabini di Marsiglia, che, nel loro consiglio del 2 gennaio 1566,
decisero di visitare i quartieri della città per cacciarne tutti quegli oziosi].
Ripetuti colpi di mano di banditi, tanto subbuglio, seppure spesso attutito,
rivela la singolare ondata di miseria dello scorcio del secolo XVI, destinata
ad aumentare ancora nel secolo successivo. Verso il 1650, probabilmente, quella
afflizione collettiva tocca il fondo. Ascoltiamo il diario inedito di G.
Baldinucci, da cui abbiamo tratto più di una notizia: nell’aprile 1650, a
Firenze la povertà è tale che non è più possibile ascoltare in pace la messa,
tanto si è importunati, durante il rito, dai miserabili «ignudi et pieni di
scabbia». Tutto, in città, è spaventosamente caro «e le arti non hanno lavoro»;
per colmo di sventura, poi, il lunedì di Carnevale, una tempesta ha distrutto
olivi, gelsi e altri alberi da frutta…».
[…]
«In
realtà, a differenza dell’Europa settentrionale dove le guerre cosiddette di
religione mascherano una serie di rivoluzioni sociali a catena, il Mediterraneo
del secolo XVI, pur di sangue vivo, vede fallire le sue rivoluzioni. Non certo
per non averle messe e rimesse in cantiere. Esso, però, è vittima di una sorta
di stregoneria. Forse perché le città furono presto smantellate, lo Stato forte
ebbe la vocazione irresistibile del gendarme? Il risultato in ogni caso, è
chiaro: si potrebbe immaginare un enorme libro dove disordini, sommosse,
assassini, misure poliziesche, rivolte si succedono e raccontano una perpetua e
molteplice tensione sociale. Alla fine, però, non esplode niente. Il libro
delle rivoluzioni del Mediterraneo è enorme, ma i capitoli non sono legati
assieme e il libro stesso, in fondo, suscita dubbi. Merita forse solo il suo
titolo?
Questi
disordini, infatti, avvengono ogni anno, ogni giorno, come semplici incidenti
stradali cui nessuno più bada, né gli autori, né le vittime, né i testimoni, né
i cronisti, né gli stessi stati. Tutti sembrano rassegnati a questi incidenti
endemici, tanto al banditismo catalano, quanto a quello di Calabria o a quello degli
Abruzzi. Ora, per un fatto citato, dieci, cento ci sfuggono, e certi
sfuggiranno sempre. I più importanti sono inoltre così piccoli, così poco
chiari, così difficili da interpretare. Che cosa fu veramente la rivolta di
Terranova in Sicilia nel 1516? Quale posto dare alla cosiddetta rivolta
protestante di Napoli nel 1561-62, occasione di una spedizione punitiva delle
autorità spagnole contro Valdesi della montagna calabrese: alcune centinaia di
uomini sgozzati come bestie? O la stessa guerra di Corsica, per tutta la sua
durata (1564-1569) e la guerra di Granada, verso la fine, entrambe decomposte
in episodi indecisi, guerre della miseria ancor più che guerre straniere o
religiose? Che cosa veramente sappiamo sui torbidi di Palermo nel 1560, sulle
cospirazioni degli “eretici” contro il duca di Mantova nel 1569? Nel 1571 i
sudditi del duca di Urbino si sollevarono contro le esazioni del loro signore,
Francesco Maria della Rovere; ma l’episodio è poco noto, di difficile
spiegazione; il ducato d’Urbino è terra di soldati mercenari; allora chi tira
le fila? La crisi interna di Genova nel 1575-76 è appena più chiara. La
jacquerie dei contadini insorti in Provenza nel 1579 (i Razas), la presa del
castello di Villeneuve e il massacro del signore del luogo, Claude de
Villeneuve, si perdono nella complicata trama delle guerre di religione
francesi al pari di molti torbidi sociali. […] Nel 1589 si erano ribellati i
sudditi del duca di Piombino, sulla costa toscana. L’insurrezione calabrese nel
1599, occasione dell’arresto di Campanella, fu soltanto un grosso fatto di
cronaca. Numerose anche le rivolte che si notano nell’impero turco dal 1590 al
1600, senza contare le sollevazioni endemiche di arabi e di nomadi in Africa
del nord o nell’Egitto, sollevazioni abbastanza vigorose di Yazigi, lo
“scrittore”, e dei suoi partigiani nell’Asia Minore, nelle quali la cristianità
pose speranze eccessive; moti di contadini serbi nel 1594 nel Banato, nel 1595
nella Bosnia ed Erzegovina, nel 1597 di nuovo nell’Erzegovina. Se a quest’elenco
incompletissimo aggiungiamo di colpo la massa fantastica dei fatti di cronaca
relativi al brigantaggio, non avremo un libro, ma un’enorme collezioni di
racconti… Sì, d’accordo: ma quegli incidenti, quegli infortuni, quel nugolo di
fatti di cronaca costituiscono forse la trama di una storia sociale valida,
che, in mancanza di altra espressione, parlerebbe quella lingua confusa, goffa,
forse ingannevole? Si tratta dunque di una coerente testimonianza in
profondità? Questo è il problema. Rispondere di sì, come facciamo noi,
significa accettare corrispondenze, regolarità, movimenti d’assieme, là dove, a
un primo sguardo, non c’è che incoerenza, anarchia, assurdità evidente.
Significa ammettere, per esempio, che Napoli “dove si ruba e si incrociano le
spade (quotidianamente) fin dalla prima ora della notte” sia teatro di
un’interminabile guerra sociale, in cui il delitto puro non ha, né può avere la
parte principale. Significa ammettere la stessa cosa per la Parigi della
primavere del 1588, ormai politicamente – anche socialmente – fanatizzata. […]
Guerra sociale, dunque crudele e a buon mercato, che fa leva su passioni e
antinomie profonde. Ora, tutti quei fatti di cronaca di cui parlavamo portano a
loro volta il segno di crudeltà sempre all’erta, dall’una come dall’altra
parte. I crimini agrari che cominciano attorno a Venezia all’inizio del secolo
sono spietati quanto le repressioni che vi tengono dietro. I cronisti, o chi
consegna quei fatti nei registri pubblici sono, di necessità, contrari a quei
fautori di disordini, di cui danno, regolarmente, un ritratto denigratorio. […]
La ferocia degli atti commessi e della repressione – questi segni dunque,
restituiscono autenticità a quei fatti di cronaca, danno ad essi un senso
dell’interminabile rivoluzione larvata che caratterizza tutto il secolo XVI e
poi tutto il XVII».
[…]
«Questo
gioco di guardie e ladri, di città oneste e di vagabondi non ha principio né
fine. È uno spettacolo permanente, una struttura. Una retata, e tutto ritorna
calmo, poi le rapine, gli assalti ai viandanti, gli omicidi si moltiplicano.
Nell’aprile 1585, a Venezia, minaccia d’intervenire il Consiglio dei Dieci. Nel
luglio 1606 a Napoli tornano a esserci troppi delitti: sono allora operate
perquisizioni notturne in alberghi e locande, nel corso delle quali vengono
fatti 400 arresti, tra cui molti soldati delle Fiandre “avvantaggiati” e cioè
“superpagati”. Nel marzo 1590 “li vagabondi, zingari, sgherri e bravazzi” sono
cacciati da Roma con otto giorni di tempo. […] In tutta l’Europa, troppo
popolata per le sue risorse, non più animata da un espansivo impulso economico
compensatore, e anche in Turchia, si prepara la pauperizzazione di notevoli
masse di uomini, tormentati dal bisogno del pane quotidiano: l’umanità che sta
per precipitarsi negli atroci conflitti della guerra dei trent’anni, quella che
Challot, testimonio implacabile, ritrarrà nelle sue incisioni, e di cui
Grimmelshausen è il cronista troppo fedele».
Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, Einaudi, volume II, 1976, capitolo V, Le Società.
Related links:
Calderón de La Barca - La vita è sogno