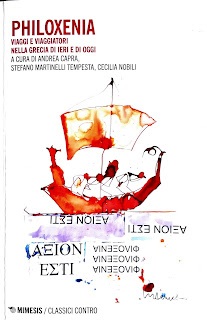Nelle pagine dei Momenti
in Grecia Hugo von Hofmannsthal ha voluto trasmetterci le impressioni
che gli suscitò il suo pellegrinaggio al tempio dell’antichità, compiuto nel
1908. Cercando quel senso del passato che gli sembrava oltremodo ambiguo, sfuggente,
così lontano dall’idea che si era fatto sui libri, si sentì quasi beffato. Eppure
quella temporalità sommersa, per certi aspetti respingente, chiusa in se stessa,
che caparbiamente rifiutava di svelarsi all’osservatore, l’avvertiva
dappertutto. A un tratto ebbe il bisogno di fermarsi, sedette all’ombra iniziando a leggere
dal Filottete. E anche qui, che lettura densa di rimandi; solo su tale
scelta si potrebbero spendere molte parole senza riuscire ad esaurirne le
implicazioni. E proprio alla fine di questo passo, in cui neppure
la poesia sofoclea ha saputo risolvere l’enigma del luogo, e ancor più, del
tempo depositato nel quel luogo, ecco riaffiorare intero il dissidio provato dallo
scrittore: «Impossibile antichità, mi dicevo, vana ricerca. – La durezza di queste parole mi ricreava. –
Nulla esiste di tutto questo. Qui dov’io pensavo di toccarlo con mano, qui è
svanito, qui soprattutto. Una demonica ironia si libra intorno a queste
macerie, che anche nel disfacimento trattengono il loro mistero».
Per un mitteleuropeo o un italiano questo “ritorno” alla Grecia può generare
significati, sfumature, interrogativi del tutto diversi. Come per i romantici
inglesi fu prevalente la ricerca degli ideali traditi, la possibilità di
ritrovare nel mito ellenico la vera essenza della poesia perduta; mentre sull’altra sponda
Caspar David Friedrich contemplava il suo mare di ghiaccio, constatazione
visiva di un’odissea sentimentale ormai pietrificata. A questo proposito rimandiamo
alle preziose osservazioni del germanista Patrizio Collini: «Il romanticismo
effettivamente presenta, in modo direi ossessivo, l’immagine del ghiaccio, l’immagine
della glaciazione dei cuori. Questa è veramente la grande immagine del
romanticismo europeo dell’Ottocento. Ci si può chiedere perché, da cosa derivi
questo topos della glaciazione, del ghiaccio onnipresente, del cuore di
ghiaccio. La motivazione di questa presenza ossessiva è di carattere economico.
Il cuore di ghiaccio è quello della moderna economia borghese, dell’assetto
spietatamente competitivo, alla base della quale c’è uno scambio simbolico. Si
cede il cuore caldo, senziente, per un cuore il quale risponde solo al principio
del calcolo, un cuore insensibile, che nei racconti romantici si presenta ora
come cuore di pietra, ora come cuore di ghiaccio. Direi che questo è un filo
unificatore di tutta la narrativa tedesca della prima metà dell’Ottocento, ma
anche della letteratura europea dello stesso periodo: la ricorrenza di questo
topos del cuore di ghiaccio, del cuore di pietra, della glaciazione, della
pietrificazione». (Patrizio Collini, Il viaggio: l’inquietudine del viandante,
1998).
Così dunque, per contrappasso, si tendeva alla Grecia come isola ultima della
bellezza, della vera vita spirituale, sola porta d’accesso al sogno dell’arte,
antidoto alla rinuncia delle ragioni del cuore. C’è evidentemente una
mediazione nella cultura di appartenenza, vi si accennava poco sopra, che influisce anche sul senso
suscitato dall’incontro con la grecità odierna. Il che ci conferma come la
Grecia divenga una costellazione policentrica e polimorfica nei diversi
contesti che l’avvicinano. Non un’unica frontiera dell’antico, piuttosto tante piccole
patrie, affatto classificabili né destinate a rimanere statiche, mai uguali a se
stesse.
In un articolo molto intenso Alessia Rovina, prendendo le mosse da un’affascinante
lettura dedicata agli “eterni ritorni” in Grecia, riflette sulle
avventurose declinazioni del viaggio che solo per la sua modesta parte emersa è
uno spostamento nello spazio, ma a un grado più profondo e durevole è uno strumento
che appresta misteriose e anomale metamorfosi dentro chi lo pratica.
(Di Claudia Ciardi)
Philoxenia: quando tutti i viaggi sono racchiusi in uno
Di Alessia Rovina
Per la rubrica «L’Argonauta»
Parrebbe
da folli, ora, parlare di viaggi. Pure, parrebbe folle aver inaugurato proprio
nel 2020 questa rubrica, battezzandola con il nome dei Viaggiatori per
antonomasia, i giovani ed acerbi Argonauti che proprio mettendo a rischio ogni
idea di sicurezza – che d’altronde si sarebbe rivelata stantia ed ingannevole,
come ricorda il Pindaro della IV Pitica (1) – decisero di farsi carico del loro destino – indi,
per taluni, della propria morte (2) – per trovare la misura di se stessi; uno
scenario di avventura ed emozione attiva purtroppo distante da quella che è
diventata la quotidianità di ciascuno, eppure tanto necessario. Necessario per
la speranza che può animare nella costruzione di una nuova Argo, una Argo
personale, metamorfica, proprio perché nata tra la complessità e le difficoltà.
Proprio perché essere Argonauti e Viaggiatori, ora, è ancora possibile.
Nei
mesi così inusuali che hanno accompagnato la sofferta transizione tra l’inverno
e la primavera di quest’anno sono venuta per caso a conoscenza di un libro
molto curioso ed affascinante, dal titolo evocativo: Philoxenia: viaggi e
viaggiatori nella Grecia di ieri e di oggi. Curiosando nel sito della casa
editrice responsabile, Mimesis, e raccogliendo notizie riguardo alla collana in
cui il volume è inserito, Classici Contro, l’ho infine inevitabilmente
acquistato. Ho atteso l’arrivo di questa densa curatela con la certezza che ne
avrei voluto parlare proprio in questo spazio, perfetto perché sarei stata
certa dell’entusiasmo e dell’accoglienza gioiosa di Claudia, ponte lirico ed
umano con una Grecia che non è rimasta cristallizzata nelle spoglie d’un
passato distante millenni, ma che continua, fiera, non convenzionale, ad essere
un polmone insostituibile del grande Mediterraneo, approdo inevitabile per chiunque
sia alla ricerca di radici (3).
Philoxenia
è un grande omaggio: anzitutto, da parte di giovani e valentissimi studiosi e
ricercatori verso il professor Giuseppe “Lello” Zanetto, loro Maestro e Guida
all’interno del “viaggio in Grecia”, un rituale antico proprio del contesto
della Statale di Milano, in cui i Classici non rimangono tracce paleografiche
stipate negli scaffali di qualche archivio universitario, slegate da ogni
collegamento, bensì prendono vita all’interno di questo pellegrinaggio verso la
sorgente da cui sono scaturiti, a contatto coi luoghi che li hanno ispirati e
di nuovo in una prospettiva che li vede rifiorire nelle liriche neogreche tanto
ricche ed elevate, canti che sanno di una spiritualità spesso trascurata, se
non del tutto sconosciuta. Secondariamente, ma non per importanza, grande è la
gratitudine verso la proverbiale ospitalità greca, la φιλοξενία del titolo, che
non si è estinta nella notte di qualche secolo addietro, ma che pulsa e non
delude mai. Nel susseguirsi dei contributi che costituiscono il volume – suddivisi
secondo un intelligente itinerario geografico, che tratta della Grecia
continentale, delle Isole e della Grecia orientale – gli studiosi si rifanno
discepoli, studenti, camminatori pronti a bere con gli occhi ed il cuore la
bellezza unica che circonda ogni angolo di Grecia – pure quell’urbanistica
tanto caratteristica del Mediterraneo orientale e sciatta che contrasta con la
maestosità dei templi e dei marmi – più
che mai disposti a permettere la metamorfosi incubata in ogni viaggio. Voci
compagne del percorso sono i viaggiatori di ieri e di oggi: i filologi
bizantini che affrontano i nubifragi al largo delle coste greche; i Fenici che
popolano i santuari marittimi delle isole greche, dedicando ex voto alle loro divinità
orientali e creando le premesse per il grande sincretismo religioso che ha
irrorato per secoli il Mare nostrum; gli osservatori di stelle di Chio, che
negli astri trovavano una commovente testimonianza della vita dopo la morte; i
poeti romantici europei, infatuati della causa greca e dell’idea di un
perpetuarsi delle grandi glorie del passato; i cantori neogreci del Novecento,
costretti ad esili politici per l’occupazione nazifascista e ad una vita che
ritrova senso se vissuta cuore a cuore con il battito del mito e degli eroi del
passato, ancora vivi sulla Terra.
L’elevatissima
qualità scientifica dei contributi ed il loro inestricabile legame con le
percezioni e gli affetti umani creano un equilibrio mirabile, che rifugge i due
principali rischi che affliggono ogni tentativo di raccontare la Grecia nella
sua interezza storica, letteraria e geografica: l’eruditismo fine a se stesso
ed il patetismo svenevole. Grande è perciò la mia ammirazione nel parlarvi e
nel consigliarvi la lettura di questo importante volume, in virtù della varietas
di sguardi di cui si compiace, provenienti da specialisti di discipline solo
apparentemente divergenti – storici, bizantinisti, classicisti, semitisti,
archeologi – della sua profondità riflessiva e poetica, tale è la trattazione
di grandi letterati neogreci altrimenti tendenzialmente taciuti, indi della sua
verità, che sono certa ogni accorto viaggiatore di geografie interiori ed
esteriori continua a sperimentare: ovverosia la ricerca, in fin dei conti, di
una verità, di un sentimento, di se stessi.
(Di Alessia Rovina, classicista e studiosa di teatro)
Note
al testo:
1. Pindaro, Pitiche, IV, vv. 327-337.
2. Apollonio Rodio, Argonautiche, vv. 77-81, 140-142.
3.
Vorrei con tutto il cuore poter dire di essere stata la prima a partorire
questo pensiero così colmo di poesia, ma devo forzatamente e con piacere
rimandare per questa riflessione ad un capolavoro cinematografico italiano
spesso ignorato: Mediterraneo, di Gabriele Salvatores, vincitore del
Premio Oscar come Miglior film straniero nel 1992. Il premio venne ritirato dal
regista con un invito rivolto al mondo, tanto garbato quanto fondamentale:
scegliere la pace, non la guerra. Gli anni erano quelli in cui i conflitti
nell’ex-Jugoslavia erano al loro apice, e nuovi orrori si preparavano, ma le
parole ed il film di Salvatores furono anche un capitolo di ammissione di colpa
e riconciliazione tra due Paesi così vicini, Italia e Grecia, resi nemici dal
vulnus del Novecento.
Edizione di riferimento del libro commentato:
Philoxenia. Viaggi e viaggiatori nella Grecia di ieri e di oggi, Mimesis, 2020
Collana: Classici contro
A cura di: Andrea Capra, Stefano Martinelli Tempesta, Cecilia Nobili
Per
una lettura del Filottete di Sofocle, sempre in questa rubrica: