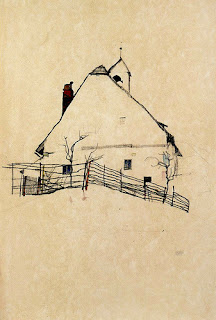Si
è da poco conclusa alla Triennale di Milano una rassegna importante dedicata ad approfondire un tema oggetto di molte attenzioni, quello dei disastri provocati da eventi naturali (alluvioni, terremoti, incendi) o
dalla guerra. Dinamiche territoriali esplorate percorrendo il doppio binario
della progettualità, di un’architettura che sappia recuperare e ripristinare i
codici identitari dei luoghi colpiti, e degli orientamenti sociali che simili
contesti esigono. La necessaria riappropriazione di uno spazio che non è solo
fisicamente dato ma ancor più definito dalla rete relazionale che nel tempo lì si
è espressa e radicata, determina lunghe, non di rado complesse, vicende contrattuali
per un possibile ripensamento del tornare a vivere laddove la quotidianità ha
subito una brusca interruzione.
Riflettendo sulla natura delle rovine e quella delle macerie, dalle più
poetiche e soffuse letture piranesiane agli squarci aperti dalle violenze novecentesche,
l’itinerario della mostra si è proposto d’indagare come queste definizioni
siano mutate durante gli ultimi tre secoli, fino a sovrapporsi nel brutale
sterminio delle recenti escalation mediorientali. La Siria, dove Palmira
diviene simbolo di questa assurda furia devastatrice che ha sabotato il
racconto dell’antico attraverso i resti greci e romani, trasformando le
passate rovine in un campo di macerie, è al centro di tale scenario sovvertito,
atomizzato, inedito. Salta la griglia concettuale di Marc Augé che individua
nelle rovine la testimonianza di un tempo distante, pacificato, nel quale il
rumore della storia si percepisce come lontano, privo della forza sconvolgente
dei fatti nel loro accadere. Qui le rovine finiscono fagocitate dalla guerra
perenne, alimentando nuove macerie. Queste “Ricostruzioni” allestite alla
Triennale hanno rappresentato dunque un’indagine ad ampio raggio che,
soffermandosi sui drammatici eventi del Novecento, si è
concentrata soprattutto sulla sequenza sismica che ha stremato il centro-sud della
penisola, dall’Abruzzo del 2009 fino alle Marche del 2016. Crisi, sradicamenti,
memorie, che sono state oggetto anche delle giornate di Paraloup nel settembre
2017, sui temi dell’abbandono e di un ritorno possibile ai luoghi della
montagna colpiti dal fenomeno dell’emigrazione di massa. E poi discussi ancora al
grande convegno internazionale Un paese
ci vuole, al Pau di Reggio Calabria, nel novembre 2018. Letture, introspezioni di
ambienti, collettività, persone che hanno ispirato pure il lavoro
documentaristico di Cecilia Fasciani, Io
prometto, opera che ha inteso dar voce a chi non si rassegna e, nelle forme
di una caparbia resilienza, che è un atto d’amore profondo per le proprie
origini e il territorio, prova a restare. Son solo tre di tante iniziative –
mostre fotografiche, dibattiti, incontri con i comitati del
cosiddetto cratere sismico – che di recente hanno acceso l’attenzione
su un argomento di assoluto rilievo, non solo perché coinvolge un’area molto estesa
dell’Italia, ma in quanto incide in profondità nel confronto su nuove forme di
sviluppo sostenibile, sulle strategie da attuare per la ripresa delle economie
locali, e in generale sul configurarsi di una ricostruzione che ha bisogno di
essere negoziata in ogni sua fase, di essere condivisa e di conservare il
legame con ciò che significava vivere certi spazi prima degli eventi che hanno
costretto la popolazione ad allontanarsi.
Conflitti, catastrofi di ieri e di oggi per medesime o simili umane aspettative. Dal sisma di Messina
alla Grande Guerra, due circostanze ravvicinate che segnano l’inizio del secolo
e mettono in campo le prime strategie di recupero dei luoghi colpiti. Tecniche
e indirizzi che saranno messi alla prova su scala più ampia e capillare dopo la
seconda guerra mondiale. Impressionanti i pannelli montati nelle sale del
Palazzo dell’Arte con l’elenco dei danni al patrimonio culturale italiano, le
riproduzioni dei monumenti colpiti, le cifre della distruzione, stime rese note
a ridosso dello scempio già nel censimento alleato del Works of Art in Italy. Di notevole impatto anche il resoconto delle
rovine tedesche quantificate in metri cubi; sono i numeri da capogiro
determinati dalla strategia dell’area
bombing, i bombardamenti a tappeto dell’aviazione inglese e statunitense,
su cui lo scrittore W. G. Sebald ha scritto un saggio lucido e molto
coinvolgente.
Nell’annientamento
di vite e cose, il dopoguerra ha anche rappresentato un nuovo inizio,
alimentando una discussione molto articolata sul come ricostruire, confluita in
un’ampia gamma di riviste che hanno trovato numerosi canali di diffusione fin dai mesi immediatamente successivi alla
liberazione. Non solo la cura per gli aspetti materiali ma anche la
valorizzazione degli elementi culturali e identitari. Le alluvioni del
Polesine, del Vajont, le devastazioni del Belice, del Friuli, dell’Irpinia,
dell’Abruzzo sono stati altrettanti banchi di prova per la messa a punto
di modelli di recupero più o meno funzionali. Dalla toccante foto del
“cimitero” della cattedrale di Venzone, ricostruita pietra su pietra, alle
criticità delle new town abruzzesi. Se ad oggi il centro dell’Aquila è
riconosciuto come il più grande intervento di restauro al mondo, il progetto
dei villaggi provvisori attorno alla città – così come dopo in Emilia la
ricostruzione di edifici rurali in assenza di linee guida o di una contestuale
e acquisita maniera d’intervento – ha creato forme di periferizzazione stabili
del territorio che ne condizioneranno inevitabilmente gli sviluppi futuri.
Un’intera
sezione è stata dedicata ai materiali a stampa – opuscoli, fogli tradotti in
inglese, cataloghi, rassegne fotografiche – di cui stupisce la quantità e
l’originalità prodotti negli anni dalle e per le zone terremotate, con
l’intento di registrare altri movimenti tellurici in quei luoghi. I moti delle
aggregazioni umane, delle difficoltà ma pure del riscatto, di un prima e di un
dopo che vengono necessariamente a fronteggiarsi in ogni esistenza. Di estrema
intensità il lavoro fotografico coordinato da Spazio Lavìl, associazione
culturale di Bologna, a firma di Fabio Mantovani e Giovanni Zaffagnini che
hanno documentato l’abbandono di una casa del maceratese, abitata per oltre un
secolo e rimasta vuota di colpo. Poesia del silenzio, racconto di una perdita
“dal di dentro”, immagini in penombra evocatrici della vita che è stata. Anche
così si riesce a dire qualcosa, anche così, posando lo sguardo sulle tracce di un’intimità
dissolta, è possibile ragionare sul perché, il dove e come ricostruire.
(Di
Claudia Ciardi)
Related links:
* Le prese sono state autorizzate dal personale della mostra.
Venzone - La cattedrale
Le Marche - Mantovani/Zaffagnini
Le Marche - Mantovani/Zaffagnini